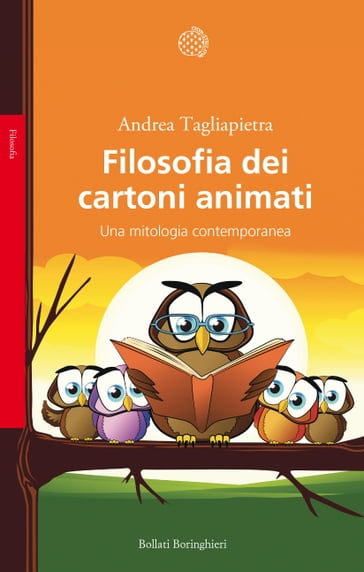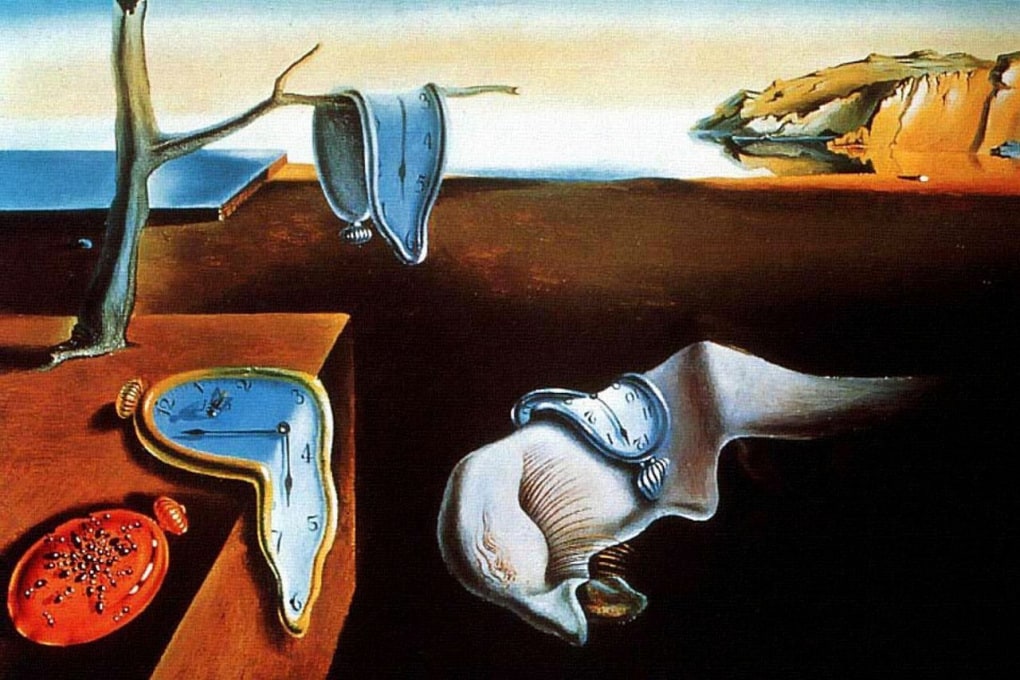“Entrare nel cinema è rientrare nel mondo, nello stesso mondo in cui ogni rappresentazione è fallita…,perché forse davvero il cinema è più grande della vita, bigger than life” enrico ghezzi.
Si può dire molto a proposito dell’ultimo film di Steven Spielberg ma alla fine questa frase di ghezzi sul cinema, quasi “lapalissiana”, ci sembra la frase giusta per rendere giustizia a un film che è al contempo un’auto-biografia, un semplice film tra tanti, un film-testamento, di uno degli autori hollywodiani più iconici e incisivi di sempre.
Spielberg: commerciale o d’autore?
Proprio come racconta il film stesso, Spielberg ha sempre navigato tra il lato “scientifico, tecnico, logico” del padre e quello “creativo, emotivo” della madre, e forse in questo stesso dualismo si nasconde una sua cifra distintiva, che lo distingue da una facile classificazione. Ci si concentra spesso sul lato contenutistico (storie semplici, universali, da botteghino…), ma quasi mai sulla capacità di giostrarsi tra i generi con disinvoltura e sulla cifra stilistica del creatore di favole cinematografiche par excellence…
E forse, proprio con questo film, Steven mette il punto sulla propria filosofia di cinema.
Pensiamo all’inizio del film (e della sua vita): il protagonista Sammy cerca di ricreare con il proprio treno giocattolo quell’incredibile esperienza irripetibile della sua prima volta al cinema. La tecnica insiste, si perfeziona, migliora, e tutto per cercare di rievocare qualcosa che in realtà è inevocabile: un incontro, con qualcosa che lo ha travolto. Ironia, a essere mostrata è proprio una scena con un treno che travolge tutto, presente nel film “Il più grande spettacolo del mondo” di DeMille (film che fu davvero il primo visto al cinema di Steven). Sammy prova a ricreare quella scena con il trenino giocattolo regalatogli dal padre, ma ecco che il trenino si rompe, la realtà è diversa dal film.
Non si potrà mai propriamente vedere ciò che Sammy ha visto davvero al cinema.
E’ il primo momento di consapevolezza di Sammy.
Il padre si arrabbia e gli ricorda che bisogna imparare a rispettare i regali ricevuti. E così accadrà per i lavori seguenti: il filmino di famiglia ” si romperà” alla scoperta, durante il montaggio delle riprese, di una relazione segreta della madre con l’amico di famiglia. Sammy mostra alla madre quanto scoperto durante le riprese, ma tutto ciò accadrà in uno stanzino buio, dove lei rimarrà da sola con le immagini proiettate sullo schermo. Per poter comprendersi (mamma Mitzi e Sammy) devono camminare su quel confine che li separa. Da qui il buio, l’unico spazio che può ospitare quell’incontro.
La cinepresa diventa letteralmente un terzo braccio. E non solo perché a un certo punto la porterà sulle spalle quasi come un’amica. Una compagna speciale come E.T., capace di essere amichevole con tutti, e la cui stra-ordinarietà e estraneità è solo la misura dei confini che separano le persone le une dalle altre. Pensate ai conflitti tra gli esseri umani, tutti presi dai propri diversi interessi elevati ad universali, incapaci di riconoscere E.T. Confondendo letteralmente il dito (quel dito) con la Luna.
In fondo è quello che Steven/Sammy vive nella sua famiglia e con i suoi coetanei, conflitti più grandi di lui e con i quali dovrà misurarsi. Per andare davvero incontro all’altro occorre “andare oltre” l’altro stesso. Essere consapevoli dello scarto che ci separa. Ecco perché l’incontro tra Sammy e sua mamma avviene per il tramite di uno stanzino buio che li separa.
“Incontro ravvicinato del terzo tipo” per richiamare un suo film. O “il ponte delle spie” per citarne un altro.
Ma non è l’essenza del cinema stesso? Come ricorda Massimo Donà nel suo “Cinematocrazia” il cinema per la sua vocazione all’universalità “sospende l’ancoraggio di un soggetto a un mondo” (riprendendo le parole di Deleuze).
Il desiderio di vedere e andare oltre , il desiderio del bambino di scoprire il mondo, di toccare l’altro, di entrare in relazione, è ciò che paradossalmente ci fa ripiombare in noi stessi, tocchiamo l’altro solo nel momento in cui prendiamo consapevolezza dello scarto incolmabile che ci separa da lui. Ecco tutto il valore del dito di E.T.
Ed ecco che Mitzi, la mamma di Sammy, prende la macchina e i bambini per guidare senza una meta precisa durante il maltempo. Sembra pazza, ma lo dicevano anche a Truman quando capisce di essere in un “reality show” e comincia a guidare come un matto in cerca dell’orizzonte fittizio. “Non permettere mai a nessuno di decidere per la tua vita” dice mamma Mitzi a Sammy, proprio come Truman capisce di essere di più di quello che il Demiurgo del reality pensava…di non essere confinabile in un orizzonte..
Quell’orizzonte che non sta mai al centro, “altrimenti è un brutto film!” asserisce perentorio John Ford nel celebre colloquio di 5 minuti con Sammy! (avvenuto realmente a Steven)
Come non ricordare il nostro Deleuze, amante del decentramento (“faccio e disfo i concetti a partire da un centro decentrato”), “Il cinema, con la variabilità dei suoi punti di vista, sospende l’ancoraggio di un soggetto al mondo” (da Immagine-movimento, Cinema 1), e ancora “”La mobilità dei suoi centri permette di accostarsi al regime acentrato dell’immagine-movimento, o piano di materia” .
Ecco perché non ci stancheremo di ripeterlo: il cinema nella sua essenza è un flusso che ci restituisce l’unicum del “qui e ora”.
Le creature di Spielberg (gli squali, i dinosauri, gli alieni…) altro non sono che l’incarnazione di questo “palloncino che si gonfia” che è il cinema. Misura di ciò che non si può misurare. “1941 allarme a Hollywood!” citando uno dei suoi primi film, che ebbe problemi nelle sale per eccessivo volume acustico…attenti alla bomba Spielberg!